Riceviamo e pubblichiamo dall’Associazione dei Ricercatori a Tempo Determinato (ARTeD).
In questa lettera – ricevuta dall’Associazione dei Ricercatori a Tempo Determinato (ARTeD) – viene descritta la struttura del pre-ruolo universitario, che negli ultimi anni ha subito numerose modifiche ed integrazioni.
> FocusUnimore > numero 57 – aprile 2025
University Researchers: Structure of the Pre-Tenure Phase
The letter from the Association of Fixed-Term Researchers (ARTeD) outlines the current structure of the Italian university pre-tenure phase, which has undergone significant changes in recent years. The pre-tenure period spans from the achievement of a PhD to the eventual appointment as an Associate or Full Professor and is often marked by contractual precariousness. The letter analyses the various types of contracts introduced by Laws 240/2010 and 79/2022, highlighting the transition from traditional research fellowships to the new Research Contracts (CDR), and the gradual replacement of Fixed-Term Researchers (RTD) with Tenure Track Researchers (RTT). It emphasises the challenging employment situation, with approximately 74% of researchers in precarious conditions and a high risk of not achieving permanent positions. Founded in 2013, ARTeD is committed to protecting the rights of precarious researchers and promoting their stable integration into the university system, working in collaboration with institutions and other organisations.
IL PRE-RUOLO
Con “pre-ruolo” si intende il periodo della vita di un docente e ricercatore dell’Università Italiana che intercorre fra il conseguimento del Dottorato di Ricerca fino alla presa di servizio come Professore Associato o Ordinario.
In questo lasso di tempo, che può durare anche una quindicina d’anni, i Ricercatori e le Ricercatrici in fieri attraversano quello che si definisce precariato universitario. Infatti, la creazione della figura del Ricercatore a Tempo Determinato (RTD), nata nel 2005 con la legge 230 (Moratti) e successivamente modificata nel 2010 con la legge 240 (Gelmini), e nel 2022 con la legge 79 (Messa/Bernini) ha provocato la precarizzazione del ruolo di Ricercatore Universitario, e si è inoltre rivelata soggetta a numerose incongruenze legislative e di difficile inserimento pratico nell’Università.
Similmente, il DL 1240 del 2024, e le successive modificazioni tuttora in atto, stanno modificando ulteriormente il quadro normativo e contrattuale del pre-ruolo.
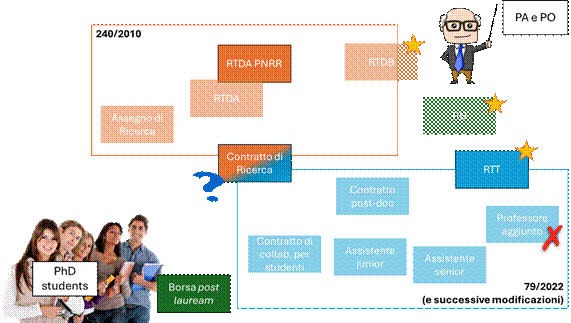
Figure contrattuali che caratterizzano il pre-ruolo universitario, a Marzo 2025.
Nella immagine sopra riportata si possono vedere le diverse figure contrattuali che caratterizzano il pre-ruolo, nel Marzo 2025. A queste vanno aggiunti i “vecchi” Ricercatori a tempo Indeterminato (RU), una sessantina circa ad UNIMORE. Quest’ultima tipologia di contratti non è più bandibile, ed oggi, nel momento in cui scriviamo, UNIMORE conta 85 RTDA, 64 RTDB, 28 RTT. I ricercatori precari rappresentano il 74% del totale, e il 18% del corpo docente. Sono inoltre presenti 568 Assegnisti di Ricerca.
Nell’immagine, le figure in arancione sono quelle nate con la legge 240/2010, quelle in azzurro sono nate con la legge 79/2022, quelle in verde sono figure preesistenti alla riforma Gelmini, e su cui pertanto non ci soffermeremo. I rettangoli in trasparenza rappresentano contratti non più -o non ancora- attivabili.
Vediamo ora nel dettaglio le figure precarie dell’Università Italiana.
Per la legge 240/2010:
- contratti di ricerca (discussi più avanti);
- Assegnisti di Ricerca: si tratta di un contratto annuale, rinnovabile per 6 anni;
- Ricercatori a Tempo Determinato di tipo A: contratti triennali, strutturati, pagati dall’Ateneo o su fondi PNRR (per brevità non ci soffermeremo qui sulle differenze fra i due tipi), e rinnovabili per massimo due anni;
- Ricercatori a Tempo Determinato di tipo B: contratti triennali, strutturati, non rinnovabili.
Le precedenti figure non sono più bandibili dal 31 Dicembre 2024, ad eccezione dei Contratti di Ricerca (si veda sotto), e di alcune forme di RTDA PNRR.
Le figure previste dalla più recente legge 79/2022 sono:
- contratti di ricerca, così come previsti nella legge 240/2010 e riportati nella 79/2022;
- contratti Post-doc, di durata variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 3 anni;
- contratti da Assistente alla Ricerca senior o junior, di durata 1 o 3 anni, e che differiscono tra di loro per le regole di eleggibilità;
- Professore Aggiunto, che consente ad un docente di prestare servizio in un Ateneo diverso dal proprio (questa figura sembra che verrà abolita);
- contratto di collaborazione per Studenti;
- Ricercatori Tenure Track, strutturati, contratti sessennali ma riducibili sotto determinate condizioni: hanno preso il posto degli RTDB.
È molto importante ricordare che tutte le forme contrattuali elencate e mostrate nell’immagine, ad eccezione di RU, PA e PO, sono contratti a tempo determinato, e fruibili per solo una volta nella vita. Per questo motivo spesso i Ricercatori e gli Assegnisti raccontano ironicamente di avere “una data di scadenza”.
Va inoltre puntualizzato che RTDB e RTT sono personale strutturato finanziato con fondi ministeriali tramite i Punti Organico (salvo alcune eccezioni dovute al PNRR), e rappresentano “l’anticamera” per a posizioni più stabili da P.A. o P.O.
Le abbiamo indicate con una stella nell’immagine, perché sono le uniche figure contrattuali a dare una qualche forma di garanzia di assunzione, a termine del contratto, a fronte della Abilitazione Scientifica Nazionale.
Ci riserviamo di discutere tali aspetti nella pagina di Frequently Asked Questions del nostro sito web e in altri futuri interventi.
Va infine notato che ad oggi le uniche forme contrattuali che gli Atenei possono effettivamente sfruttare, sono quelle con lo sfondo colorato, ovvero le Borse post lauream, gli RTT, ed alcune forme di RTDA PNRR, ma solo per alcuni mesi ancora.
I Contratti di Ricerca, che hanno preso il posto degli Assegni di Ricerca, sono oggetto della prossima sezione. Ciò fa coppia con la cessazione della possibilità di bandire le altre figure del 240/2010, avvenuta il 31 Dicembre 2024, e che insieme al recente taglio delle risorse per il sistema universitario ha creato una “bolla temporale” in cui Atenei non possono assumere personale post-doc, salvo alcune eccezioni. In questo momento siamo nella fase finale di questa “bolla”.
Il Contratto di Ricerca (CDR) è un rapporto di lavoro subordinato, a cui si può accedere previo conseguimento del titolo di PhD (o di specializzazione per l’area medica) e se questo verrà acquisito entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando. Come detto, ad oggi è l’unica forma contrattuale prevista come post-doc non strutturato, prima della figura da RTT.
Il CDR è di durata biennale, con possibilità di rinnovo di una sola volta e prorogabile di un ulteriore anno per specifiche necessità progettuali. La durata complessiva non può quindi superare i 5 anni.
UNIMORE sta lavorando al regolamento interno ed è stato creato un gruppo di lavoro inter-universitario perché ad oggi ci sono ancora aspetti da chiarire, in merito ad esempio anche all’importo corrisposto. Il CDR dovrebbe prevedere una retribuzione compresa tra quella del Ricercatore a tempo definito e quella del Ricercatore a tempo pieno, ovvero si prevede una retribuzione annua lordo dipendente minima di 28.283,94 euro (costo lordo amministrazione di 39.547,14 euro), massima di 39.706,71 euro (costo lordo amministrazione di 54.389,34 euro).
Il CDR costituisce reddito IRPEF, riceve contributi pensionistici e gode di diritti tipici dei lavoratori quali controlli sanitari, malattia, sostegno alla maternità e alla paternità, legge 104, congedo straordinario per infermità e aspettativa per motivi di famiglia.
L’iter burocratico ministeriale per definire questa forma contrattuale è stato completato nell’ultimo mese.
Dietro richiesta di ARTeD, il Ministero ha pubblicato un documento di FAQ in cui è chiarito (si veda qui, all’Art.9) che è possibile per gli RTDA ed ex-RTDA partecipare a bandi per CDR, mentre ciò non sarà possibile per RTDB e RTT.
Il nostro Ateneo ha recentemente emesso il proprio regolamento relativo ai Contratti di Ricerca, disponibile qui. Relativamente all’ammissibilità di RTDA ed ex-RTDA, al momento sembrerebbe (Art.7) escludere genericamente coloro che abbiano fruito di un contratto da Ricercatore a Tempo Determinato secondo la legge 240 del 2010. Tuttavia, seppur non esplicitato nel regolamento, le linee guida (link) escludono solo i RTT, recependo l’interpretazione espressa dal Ministero nelle FAQ sopracitate. UNIMORE ha richiesto chiarimenti al Ministero in tal proposito, e i nostri uffici sono in attesa di una risposta.
I NUMERI IN ITALIA E IN UNIMORE
Per concludere, e dare un’idea dei numeri di cui si parla, a Settembre 2024 si contavano in Italia circa 30.000 ricercatori precari, indicativamente rappresentanti di ¼ del corpo docente totale.
Abbiamo stimato che una percentuale fra l’80% ed il 90% di queste persone non potrà essere regolarizzata per assenza di risorse, e pertanto perderà il proprio posto di lavoro. Questo processo è già in atto da diversi mesi, ed è chiaramente visibile per RTDA e RTDB nella tabella sottostante, che riporta i dati relativi ad UNIMORE.
In ultimo, vale la pena ricordare che l’età media italiana dei Ricercatori e delle Ricercatrici a tempo Determinato è fra i 36 e i 37 anni.
| Qualifica | 01/10/2024 | 01/04/2025 |
| Ricercatore – RU | 65 | 62 |
| Ricercatore a t.d. – t.defin. (art. 24 c.3-a L. 240/10) – RTDA | 1 | 1 |
| Ricercatore a t.d. – t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) – RTDA | 103 | 84 |
| Di cui su fondi PNRR | Dati non disponibili | Dati non disponibili |
| Ricercatore a t.d. – t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) – RTDB | 94 | 64 |
| Ricercatore a t.d. – t.pieno (L. 79/2022) – RTT | 12 | 28 |
| Assegnisti | 523 | 568 |
Fonte dei dati: database ministeriale CINECA
ARTeD: CHI SIAMO?
L’Associazione dei Ricercatori a Tempo Determinato (ARTeD) è un’associazione senza fini di lucro, non sindacale, apolitica ed apartitica, fondata nel 2013 a Roma da un gruppo di 16 Ricercatori provenienti da diversi Atenei italiani fra cui il “nostro” Andrea Padovani, ora Professore Associato al DIEF (primo a destra nella foto).

L’Art.1 dello Statuto recita gli obiettivi primari dell’Associazione:
- promuovere e tutelare i diritti dei Ricercatori a tempo determinato, nonché favorire il loro inquadramento in ruolo come docenti universitari a tempo indeterminato;
- promuovere la parità di trattamento rispetto ai Ricercatori a tempo indeterminato;
- migliorare la rappresentanza dei Ricercatori a tempo determinato negli organi di governo degli Atenei;
- dialogare con i soggetti istituzionali al fine di contribuire al perfezionamento della disciplina relativa ai Ricercatori a tempo determinato;
Come detto, l’Associazione non ha connotati sindacali né finalità politiche o partitiche, ma è aperta a dialogo ed iniziative con qualsiasi soggetto che sia interessato a discutere e promuovere le tematiche a noi care. Ad oggi, i rapporti più stretti sono con diverse figure governative e parlamentari, nonché con alcuni partiti dell’opposizione. Al di fuori delle aule parlamentari, i dialoghi più intensi sono con FLC-CGIL, l’Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani (ADI), Unione Degli Universitari (UDU), Rete 29 Aprile, solo per citare alcune realtà.
Possono diventare soci di ARTeD tutti e tutte gli RTDA, RTDB e RTT italiani/e, seppure le attività dell’associazione portino beneficio genericamente a tutte le figure precarie della ricerca universitaria italiana, come ad esempio gli Assegnisti di Ricerca o i futuri Contrattisti. L’iscrizione è gratuita, e le spese strutturali dell’Associazione sono sostenute tramite donazioni.
A livello dei singoli Atenei, i Ricercatori afferenti ad ARTeD costituiscono una sede locale, con un rappresentante (per UNIMORE, Dott. Paolo Burgio del FIM), ed un comitato, di cui ad UNIMORE fanno parte Dott.ssa Mattia Pia Arena (DSV), Dott.ssa Giulia Brigante (BMN), Dott.ssa Chiara Chiavelli (SMECHIMAI), Dott.ssa Chiara Franceschini (FIM – anche componente del Senato Accademico), Dott. Giuseppe Montevecchi (DSV), Dott. Niccolò Morisi (CHIMOMO), Prof. Andrea Padovani (DIEF) e Prof.ssa Anna Elisabetta Vaudano (BMN).
Le sedi locali ARTeD hanno il compito di svolgere nell’ambito del proprio territorio, iniziative compatibili con gli indirizzi generali dell’Associazione, e di collaborare con gli organi istituzionali degli Atenei per promuovere e tutelare i diritti di tutti gli RTD. Tutti gli iscritti ad ARTeD in un Ateneo formano l’Assemblea, che viene convocata con cadenza annuale per discutere le varie tematiche di interesse. Per il 2025, l’Assemblea si è tenuta in occasione del nostro primo “compleanno”, in data 11 Aprile alle ore 18, presso il DIEF.
Recentemente, ARTeD UNIMORE ha lanciato la propria pagina web (link) con una sezione aggiornata di FAQ che vuole fornire informazioni pratiche ai Ricercatori e alle Ricercatrici, in questo periodo storico caratterizzato da una generale incertezza e da poca informazione sul processo di riforma universitaria in atto.
